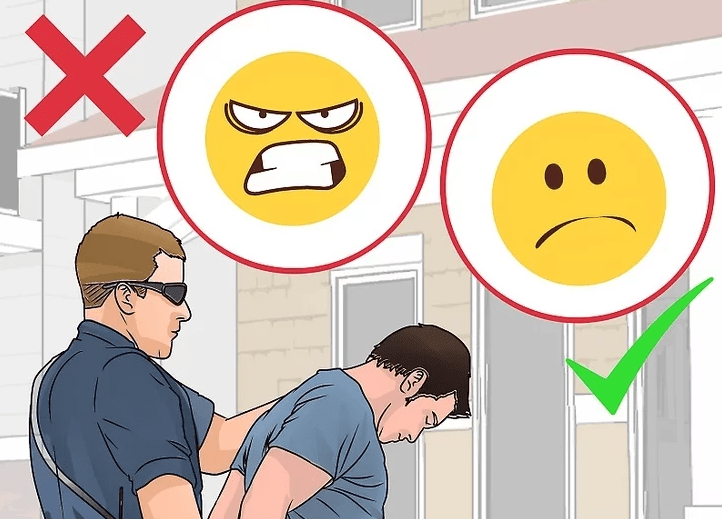Un nostro assistito ha ottenuto una soddisfacente assoluzione del Tribunale di Messina perché il fatto non sussiste, accogliendo pienamente le nostre tesi difensive.
Il reato contestato era relativo alla coltivazione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 comma 1, D.P.R. n. 309/1990
Tale norma punisce la coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti (o psicotrope), indipendentemente dalla destinazione della sostanza.
In particolare, la norma equipara la coltivazione ad altre condotte, quali la fabbricazione e la produzione di stupefacenti.
La fattispecie de quo è costruita in termini di reati di pericolo astratto e pone alla base l’esigenza di tutela del bene della salute fisica e psichica, compromessa dall’assunzione di sostanze stupefacenti.
Il comma 1bis dell’art. 73 concerne invece, tra gli altri, il reato di detenzione illecita, ad esclusione dei casi in cui lo stupefacente appaia destinato ad un uso esclusivamente personale.
La scelta del legislatore si è sempre orientata nel senso di punire soltanto le condotte volte alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e non anche quelle destinate ad un consumo esclusivamente personale delle stesse.
L’uso esclusivamente personale è, infatti, punito a titolo di illecito amministrativo dall’art. 75 D.P.R. n. 309/1990.
Le condotte di importazione, esportazione, acquisto, ricezione e detenzione di stupefacenti, se per uso esclusivamente personale, rappresentano dei fatti non punibili, ma sanzionabili in via amministrativa con apposita ordinanza prefettizia.
Sono escluse dall’alveo dell’art. 75 le condotte di coltivazione, fabbricazione e produzione di sostanze stupefacenti le quali, dunque, stante un’interpretazione letterale ( a contrario ) della norma, mantengono rilevanza penale a prescindere dalla destinazione – ad uso personale o per spaccio – del prodotto ricavato.
In particolare, occorre verificare se la suindicata condotta possa integrare il reato di coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990 o se sia possibile assimilarla, per l’effetto, alla detenzione che, se finalizzata all’uso personale, non costituisce reato, ma sanzione amministrativa (art. 75 D.P.R. n. 309/1990).
Orbene, come già accennato, la coltivazione di sostanze stupefacenti non rientra tra le condotte di cui all’art. 75 co.1 del D.P.R. n. 309/1990 ed integranti un illecito amministrativo.
La scelta del legislatore sembrerebbe chiara: la condotta di coltivazione, a prescindere dalla destinazione ad uso personale o meno della sostanza psicoattiva ricavata, è sempre penalmente rilevante e quindi punibile.
Nonostante l’apparente chiara formulazione, l’art.75 sopracitato ha dato vita ad un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, sia in ordine alla concreta punibilità della condotta di coltivazione, alla luce del principio di necessaria offensività – soprattutto nei casi in cui il quantitativo di sostanza ricavabile dalla pianta sia esiguo, ossia tale da non offendere il bene giuridico tutelato dalla norma (la salute), neanche nella forma della mera messa in pericolo – sia in ordine alla possibilità di ricondurre questi casi alla disciplina inerente la destinazione ad uso personale, atteso che la condotta di coltivazione non è richiamata dall’art. 75.
Sulla questione sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n.12348/2020, depositata il 16.04.2020.
La Suprema Corte ha invero sancito l’irrilevanza penale della coltivazione domestica di sostanze stupefacenti finalizzata esclusivamente al consumo personale, raggiungendo in via ermeneutica un risultato al quale i nostri giudici di legittimità, ma anche costituzionali, si erano sinora sempre rifiutati di pervenire.
La soluzione offerta dalle Sezioni unite è riassunta nel principio di diritto secondo cui «il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore».
La Corte di Cassazione, dunque, da un lato circoscrive la nozione di coltivazione ad uso domestico, distinguendola dalla coltivazione tecnico-agraria cui farebbe riferimento l’art. 73 ed individua contestualmente i parametri dai quali si deduce la destinazione ad uso personale della sostanza ricavata; dall’altro, dichiara la non punibilità della condotta di coltivazione se ricorrono tali parametri, per come indicati nel suddetto principio di diritto.
Al fine di analizzare le argomentazioni poste a fondamento della sentenza n. 12348/2020 e, quindi, per meglio comprendere il ragionamento logico-giuridico seguito dalle Sezioni Unite, è utile ripercorre alcune tappe giurisprudenziali di grande interesse, con particolare riferimento al principio di offensività applicato al reato di coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti.
Come è noto, tale principio opera in una duplice prospettiva: la c.d. “offensività in astratto”, secondo cui il legislatore è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione; e la c.d. “offensività in concreto”, ossia quel criterio interpretativo che deve orientare il giudice comune nell’operazione di sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma punitivo astratto, inducendolo a non ritenere integrato il reato quando la condotta sia priva di qualsiasi attitudine lesiva.
L’applicazione di tali principi alla disciplina degli stupefacenti ha indotto la Corte Costituzionale a dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 d.P.R. 309/1990 in due principali occasioni.
Nella sentenza n. 360 del 1995 la Corte ha evidenziato l’insussistenza della denunciata disparità di trattamento della condotta di coltivazione, prevista e punita soltanto penalmente dall’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, rispetto a quello previsto per le condotte di detenzione, acquisto e importazione di sostanze stupefacenti, sanzionate invece in via amministrativa quando finalizzate al consumo personale.
Queste ultime, infatti, sono condotte collegate immediatamente e direttamente all’uso della sostanza stupefacente: nella detenzione, acquisto ed importazione il quantitativo di sostanza stupefacente è certo e determinato e consente, unitamente ad altri elementi attinenti alle circostanze soggettive ed oggettive della condotta, la valutazione prognostica della sua destinazione. Al contrario, nel caso della coltivazione tale nesso di immediatezza manca, sicché la correlata valutazione della destinazione ad uso personale, piuttosto che allo spaccio, risulta maggiormente ipotetica e meno affidabile.
Per tali ragioni la Corte ribadisce la compatibilità con il principio di offensività in astratto della costruzione della fattispecie di coltivazione nei termini di reato di pericolo presunto, così che non appare irragionevole che il legislatore sanzioni penalmente anche l’approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale. Spetta poi al giudice di merito la verifica dell’offensività in concreto della condotta, la cui eventuale mancanza va ricondotta nell’alveo del reato impossibile ex art. 49 c.p.
Alle medesime conclusioni è giunto il giudice delle leggi anche in tempi più recenti, con la sentenza n. 109 del 2016.
In tale occasione si è ribadito che l’atteggiamento più rigoroso del legislatore nei confronti della condotta di coltivazione non è irragionevole, data la sua attitudine a innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate o predeterminabili. Inoltre, si è osservato che il giudice di merito può pervenire a constatare l’assoluta inidoneità della condotta di coltivazione a porre a repentaglio il bene giuridico protetto (ovvero la salute) «sia – secondo l’impostazione della precedente sentenza del 1995 – facendo leva sulla figura del reato impossibile (art. 49 del codice penale); sia – secondo altra prospettiva – tramite il riconoscimento del difetto di tipicità del comportamento oggetto di giudizio».
In definitiva, secondo la Corte Costituzionale, la scelta del legislatore di ritenere più pericolosa la condotta di coltivazione rispetto a quella di consumo, tanto da punire la condotta di coltivazione in sé, prescindendo dall’uso personale o meno della sostanza ricavata, è ragionevole ( id est conforme al principio di offensività in astratto) e trova una sua giustificazione nei diversi motivi suesposti.
Nel solco dell’orientamento della giurisprudenza costituzionale si inserisce anche la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza Di Salvia a Sezioni Unite del 2008 , è pervenuta al medesimo risultato di ritenere penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante, dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando la coltivazione sia realizzata allo scopo di destinare il prodotto ad un uso esclusivamente personale.
Sul piano dell’offensività in astratto, le Sezioni Unite hanno fatto riferimento agli argomenti già evidenziati dalla Corte Costituzionale: quello del difetto del nesso di immediatezza tra la coltivazione e il consumo, e quello ontologico-naturalistico secondo cui la coltivazione è suscettibile di creare nuove e non predeterminabili quantità di sostanza stupefacente.
La Cassazione nel 2008 ha rilevato, inoltre, che non sussiste alcun fondamento normativo che giustifichi una distinzione tra la coltivazione “tecnico-agraria” e la coltivazione “domestica”. Per la coltivazione lecita di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, gli articoli 27 e seguenti del d.P.R. 309/1990 stabiliscono una serie di stringenti condizioni (la disponibilità di un terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, ecc.) volte a ottenere la necessaria autorizzazione. Ma ciò non significa che, ove non sussistano tali condizioni, e dunque non vi sia una coltivazione in astratto suscettibile di essere autorizzata, allora possa affermarsi che si sia di fronte a una attività lecita.
Le Sezioni unite del 2008, non hanno introdotto alcuna novità sul piano dell’offensività in concreto, limitandosi a rilevare che la condotta è inoffensiva quando non leda o ponga in pericolo il bene tutelato, nemmeno in grado minimo.
In seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite 2008, si sono sviluppati due distinti orientamenti giurisprudenziali sul concetto di offensività in concreto.
Secondo un primo orientamento, sarebbe irrilevante la verifica dell’efficacia drogante delle sostanze ricavabili dalle colture al momento dell’accertamento della polizia giudiziaria; rileverebbe invece il giudizio predittivo sull’attitudine della pianta, conforme al tipo botanico vietato, di giungere a maturazione e produrre sostanze a effetto stupefacente, anche in relazione all’esito del suo fisiologico sviluppo e alle modalità di coltivazione (ex multis Cass. Pen.n. 44136/2015, Cass. Pen.n. 2618/2015).
Secondo un opposto orientamento, non sarebbe sufficiente la verifica della conformità della pianta coltivata al tipo botanico proibito e della capacità della sostanza, ricavata o ricavabile, a produrre un effetto drogante, ma sarebbe necessaria la sussistenza di un ulteriore elemento: il pericolo concreto di aumento della disponibilità di stupefacente e di diffusione dello stesso ( Cass. Pen. n. 8058/2016, Cass.Pen. n.5254/2020).
Si è quindi giunti a escludere l’offensività in concreto per la modesta entità della coltivazione e del principio attivo ricavato (ad esempio nel caso di un’unica pianta in vaso, contenente una piccola quantità di principio attivo, ex multis Cass. Pen. n. 40030/2016, Cass. Pen. n. 25674/2011). Ed ancora, facendo perno sulla distinzione tra tipicità e offensività già sottolineata dalla sentenza n. 109/2016 della Corte costituzionale, si è affermata l’assenza di tipicità della condotta nei casi di mancanza di un qualunque effetto stupefacente nella sostanza prodotta o coltivata (Cass. Pen. n. 36037/2017).
A dirimere il suddetto contrasto sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite nel 2020, con la sentenza n. 12348, dep. il 16 aprile 2020.
In tale pronuncia, le Sezioni Unite dichiarato l’irrilevanza penale della condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti in presenza di indici rivelatori di una sua realizzazione in forma domestica, sottolineando in primo luogo la necessità di superare il concetto di incremento del mercato degli stupefacenti, in quanto caratterizzato da intrinseca vaghezza e difficoltà di accertamento.
La Corte ribadisce poi la distinzione tra il principio di tipicità e di offensività.
La tipicità, intesa come riconducibilità del fatto concreto alla fattispecie normativa astratta, è requisito imprescindibile per verificare la sussistenza del reato di coltivazione di stupefacenti. Essa implica che la pianta rientri nella categoria botanica proibita e che sia idonea, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.
Le Sezioni Unite rilevano che la tipicità (non l’offensività) concerne l’ambito di applicazione della tutela penale. Al riguardo, viene in rilievo il concetto di coltivazione, rispetto al quale non è possibile attribuire rilevanza penale a qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione. Le Sezioni Unite del 2020 prendono così le distanze dall’affermazione della sentenza Di Salvia del 2008, secondo cui ha rilevanza penale qualsiasi attività di coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto a uso personale.
Fermo restando la distinzione tra la nozione di coltivazione e quella di detenzione, il Collegio ritiene però che debba procedersi a un’interpretazione restrittiva del reato di coltivazione non autorizzata di sostanza stupefacenti, che escluda dall’area penalmente rilevante la coltivazione di minime dimensioni finalizzata esclusivamente al consumo personale, in un’ottica garantistica e di bilanciamento con l’esigenza di anticipazione della tutela.
A tal fine valorizza ( sempre in senso contrario alla sentenza di Salvia ) la disciplina prevista dagli articoli 27 e seguenti del d.P.R. 309/1990, la quale evoca una coltivazione “tecnico agraria” di apprezzabili dimensioni, ontologicamente volta a creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti, e non limitata dunque all’ambito domestico.
Le Sezioni unite non si limitano a stabilire che la coltivazione domestica non rientra nel tipo di coltivazione previsto dall’art. 73 d.P.R. 309/1990, ma indicano anche il criterio utile a distinguere la coltivazione domestica da quella penalmente rilevante: la prevedibilità della potenziale produttività di sostanza stupefacente.
Tale parametro deve essere ancorato a presupposti oggettivi – che devono essere tutti compresenti perché la condotta sia penalmente irrilevante – quali la minima dimensione della coltivazione, lo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, le rudimentalità delle tecniche impiegate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di un inserimento dell’attività nell’ambito del mercato degli stupefacenti, l’oggettiva destinazione del prodotto all’uso esclusivamente personale del coltivatore. Non sarebbe invece sufficiente a escludere la tipicità del fatto l’intenzione di soddisfare esigenze di consumo personale, trattandosi di una circostanza puramente soggettiva.
Quanto al versante dell’ offensività della condotta di coltivazione, la Corte sottolinea che l’esclusione della punibilità delle attività di coltivazione domestica già sul piano della tipicità confermi le posizioni della giurisprudenza maggioritaria, che considera la coltivazione (tecnico-agraria), la fabbricazione e la produzione più pericolose rispetto alle altre condotte elencate nell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Tali attività incrementano la provvista esistente di stupefacente, dunque sono ragionevoli una differente disciplina e un’anticipazione di tutela del bene della salute collettiva e dei singoli.
Ciò posto, assume rilevanza la valutazione dell’offensività in concreto, quale criterio interpretativo a disposizione del giudice, che è tenuto a verificare che il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene-interesse tutelato.
Considerato che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, secondo la Suprema Corte il giudice di merito deve diversificare il tipo di verifica a seconda del grado di sviluppo della coltivazione al momento dell’accertamento.
Se il ciclo di maturazione è completato, si esclude la sussistenza del reato in assenza di principio attivo necessario per produrre effetto drogante.
Nelle fasi pregresse, le modalità di coltivazione rilevano per verificare l’attitudine della pianta a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.
La punibilità sarà esclusa in caso di un’attuale coltivazione inadeguata, da cui possa evincersi che la pianta non sarà in grado di realizzare il prodotto finale.
Parimenti, non vi è punibilità se il risultato finale della coltivazione non consenta di ritenere il raccolto conforme al normale tipo botanico, o abbia un principio attivo troppo povero per la utile destinazione all’uso quale droga.
In conclusione, la Corte sottolinea come la soluzione a cui perviene si ponga in conformità con l’ordinamento sovranazionale, e in particolare con la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea n. 2004/757/GAI, che fissa le norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Tale decisione quadro, infatti, impone agli Stati membri di configurare come reato anche la coltivazione della cannabis, ma esclude dal proprio campo applicativo le condotte (coltivazione compresa) finalizzate al consumo personale dello stupefacente.
All’esito della lunga e completa ricostruzione, le Sezioni unite sottolineano che la risposta punitiva all’attività di coltivazione attuata dal legislatore italiano risulta graduata nel modo seguente:
«a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo – alle condizioni sopra elencate – per mancanza di tipicità, nonché la coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente, per mancanza di offensività in concreto;
b) la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990;
c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l’art. 131-bis cod. pen., qualora sussistano i presupposti per ritenere la particolare tenuità, nonché, in via gradata, l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto».
Nel caso in esame, il Tribunale di Messina ha riconosciuto la nostra tesi difensiva che puntava alla mancanza di prova certa del fatto che la sostanza ricavabile dalla coltivazione fosse idonea a produrre un effetto stupefacente, stante l’assenza di qualsivoglia sottoposizione del narcotest alla sostanza drogante sequestrata.
Infatti, la mancanza di esami chimico-tossicologici da parte degli inquirenti sulla sostanza non ne hanno consentito di verificare l’idoneità produttiva della stessa.
Oltre a tale elemento, ha rilevato anche la circostanza che lo stesso nostro assistito fosse in cura presso il Sert per abuso continuo di oppioidi da oltre un decennio.
Pertanto, il Tribunale di Messina ha valutato che il compendio probatorio delineato, avuto riguardo alle connotazioni della condotta in esame, poteva far ritenere che l’attività di coltivazione cui il nostro assistito aveva dato luogo, specie in assenza di esami tossicologici idonei a riscontrare il quantitativo di principio attivo estraibile, fosse priva di offensività penale, assolvendo così il nostro assistito dal reato ascrittogli.